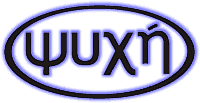Quando lo psicoterapeuta inizia a trattare una paziente
come Antonella, di 22 anni - che chiameremo "Stivaletti Rossi"
per il suo modo di vestire (stivaletti rossi da ballerina, corpino rosso,
gonna nera svasata) - subito ha la sensazione di avere incontrato una
persona psichicamente scarsamente integrata e i cui pensieri si svolgono
ad un livello così rudimentale da renderla spesso incapace di
differenziare pienamente gli oggetti della realtà esterna dagli oggetti
interni prodotti dalla immaginazione.
La fragilità della paziente può provocare nel terapeuta delicati
sentimenti di tenerezza, analoghi a quelli che suscitano i bambini quando
sono molto piccoli; e non a caso il terapeuta può scoprire di stare
pensando ai propri figli mentre la paziente è lì accanto in mutacico
silenzio con una metà del viso coperta da una lunga chioma di capelli che
le scende sulle spalle. Il timore che l'Io della paziente possa
ulteriormente frammentarsi costringe il terapeuta ad una continua
attenzione, preoccupato di potere sbagliare atteggiamento e modi verbali,
solo di rado può sentirsi più libero.
D'altro canto la paziente difficilmente dà occasioni si sollievo: durante
una seduta dà la sensazione che stia uscendo dalla sua chiusura autistica,
che stia per aprirsi alla comunicazione, che stia per gratificare gli
sforzi del terapeuta diretti a restringere il vallo relazionale e, invece,
la seduta dopo Antonella si presenta visibilmente depressa, totalmente
chiusa in sé; ha cambiato abbigliamento: calza degli stivaletti gialli e
porta dei pantaloni viola; i capelli, che la seduta prima teneva raccolti
in due trecce che le liberavano il volto, oggi coprono cupamente i suoi
occhi; il silenzio è di tomba.
Il terapeuta ha la sensazione di trovarsi di fronte ad un essere che ha
perduto le categorie logiche attraverso le quali viene ordinato l'universo
esperienziale: il tempo è diventato probabilmente soltanto movimento del
corpo; i luoghi forse hanno assunto valenze fortemente simboliche
dispiegate lungo dimensioni surreali.
Antonella, la cui madre è una schizofrenica per lungo tempo ricoverata in
Ospedale Psichiatrico, dà l'impressione come di cercare di raccapezzarsi
in un labirinto (intrico complesso di relazioni e di oggetti
internalizzati) entro cui l'Io sembra irrimediabilmente disperso, non più
sufficientemente differenziato. Il terapeuta, durante le sedute, prova
anch'egli la sensazione di una scarsa differenziazione del proprio lo, di
una perdita della identità personale che, pertanto, tende a recuperare
prontamente per non vivere anch' egli una esperienza psicotica. La paura
di questa esperienza riattiva in esso, in modo straordinario, i processi
razionali e coscienti i quali, così mobilitati diventano il principale
impedimento allo sviluppo di una relazione terapeutica che si possa
snodare ad un livello ancora più profondo.
In una fase ancora successiva, sono trascorsi circa quattro mesi, il
silenzio durante le sedute è bene accolto da tutti e due i partners del
processo psicoterapeutico. A ciò contribuisce, oltre il bisogno di
evitare l'intensa angoscia che può mobilitare in entrambi ogni ricerca
possa riportare in primo piano la drammaticità della realtà esistenziale
della paziente, anche la profonda gratificazione che deriva dal prodursi,
nella fase simbiotica della relazione terapeutica, di emozioni e di
sentimenti difficilmente traducibili in pensieri razionali ed in parole,
trattandosi di contenuti perduti e difficilmente rivivibili in quanto
appartenenti ad epoche arcaiche dello sviluppo individuale.
Finalmente accade, un giorno, che la paziente si presenti alquanto
sorridente e più libera di muoversi nella stanza dove si svolgono le
sedute, cosi lei può più facilmente alzarsi e recarsi presso la finestra
per osservare fuori la pioggia che cade a dirotto. Il terapeuta sente che
la paziente si sta attaccando a lui e si chiede se Antonella non stia
fantasticando inconsciamente di una madre che le si avvicini e se la
stringa al seno. Ma quando la seduta successiva la giovane si presenta di
nuovo abbattuta e cupa, il terapeuta si sente deluso, frustrato; reputa il
proprio compito immane, fatto di attese interminabili, salvo prendere
alcuni appunti e di tanto in tanto offrire degli stimoli verbali, ma con
la sensazione che la maggior parte delle proprie parole possa cadere nel
vuoto senza lasciare alcuna traccia.
Altre volte Antonella sembra rivitalizzarsi; si fa sentire attraverso i
suoi sospiri, come una "bella addormentata nel bosco" che si
stia svegliando, che stia per liberarsi dall'incantesimo mortifero. In
questa fase la paziente sembra alla ricerca di un modulo personale; quando
si decide a comunicare qualcosa verbalmente, una stessa parola la ripete
tre volte, dapprima con un sussurro, poi sottovoce, infine con un tono di
voce normale. Ha cambiato look: gonna e camicetta nere, stivaletti
bianchi, capelli intrecciati alla vichinga; un costante velato sorriso
sulle labbra.
Il terapeuta avverte un tenue affacciarsi nel la paziente di un livello
seduttivo ed erotico, un riaffiorare della libido e della sessualità.
Nelle sedute successive Antonella sembra tollerare poco che il terapeuta
prenda appunti e comincia a guardarlo fissamente in volto; trascorsi
alcuni giorni ancora, mentre egli sta prendendo degli appunti la paziente
gli si avvicina molto, quasi a voler cercare un contatto epidermico e un
calore umano attraverso la vicinanza corporea. Ciò nonostante il
terapeuta non può non riflettere sul fatto che dopo diversi mesi di
trattamento egli non è ancora riuscito a modificare la tendenza da parte
di Antonella, durante le sedute, a mantenere un silenzio quasi assoluto.
Gli viene in mente che forse inconsciamente lui stesso ha temuto il
modificarsi di questo assetto, come se l'abbandono del silenzio possa
facilitare l'emergere nella paziente delle angosce primarie, quelle che
l'hanno resa così vulnerabile dal punto di vista psicoemotivo.
Antonella pian piano sembra sempre meno confusa ed ha una diversa
attenzione nei confronti dell'ambiente circostante; infatti comincia ad
osservare molte cose: i mobili della stanza, i libri disposti sul tavolo,
i disegni dei rivestimenti. Ma si tratta di cambiamenti minimi perché nel
complesso Antonella tende a mantenere con il terapeuta una relazione come
se con la madre schizofrenica.
Dopo circa sette mesi dall'inizio della terapia la paziente fa registrare
ulteriori progressi; finalmente ha cominciato a colloquiare con il
terapeuta, anche se in modo titubante e sconnesso; e comunque parla
solamente di abiti, di moda, di acconciature. Ma alcune sedute dopo, ad un
certo momento, chiede al terapeuta di andarla a trovare a casa, gli
offrirebbe il caffè; aggiunge che pur non vivendo da sola lei si sente
molto sola. La paziente, che da tempo ha sviluppato dei vissuti
persecutori relativamente ai propri familiari, evidentemente intravede nel
terapeuta una figura amica e protettiva.
Antonella non è ancora in grado di affrontare un lavoro più analitico
infatti le interpretazioni o le domande dirette a favorire un suo maggiore
insight provocano regolarmente comportamenti stereotipi di fuga; in tali
occasioni la paziente si alza di scatto e va a procurarsi una sigaretta
nella sala di attesa per tornare subito dopo con la sigaretta accesa.
L'unico modo per evitare questi comportamenti è il mantenere una
posizione apparentemente passiva, il riuscire a fungere da contenitore del
non detto, come una sorta di raccoglitore delle parti più confuse e più
oscure della paziente. Questa necessità di auto-limitazione provoca nel
terapeuta un recondito fastidio di cui ora ha maggiore possibilità di
rendersi conto.
Attorno al nono mese di terapia, durante una seduta, Antonella presenta
un'altra novità. Prende una rivista posta sulla scrivania e comincia a
sfogliarla; ad un certo punto appare attratta e turbata da un’immagine
su cui si sofferma a lungo. Il terapeuta è abbastanza contento; è la
prima volta che vede la sua paziente intensamente interessata a qualcosa;
è pure la prima volta che vede trasparire in lei una emozione non fatua e
priva di ottundimenti difensivi. Ma la seduta dopo e nelle altre
successive Antonella ripropone gli atteggiamenti soliti da
"sirenetta", tutta sorrisi ed occhi dolci. Solo in
un’occasione avviene qualcosa di diverso: Antonella sembra intenta a
studiare il suo terapeuta e a cercare di capirlo, forse anche desiderosa
di aiutarlo come se lo avesse sentito in difficoltà, bisognoso di
sostegno.
Attorno al decimo mese di terapia, nel corso di una seduta, ad un tratto
la paziente rivolge al terapeuta questa frase "lei sinora non mi ha
aiutato" e poi aggiunge "Non mi può visitare? Ho l'utero
infiammato. Mi può aiutare? A me serve l'utero perfetto, non ammalato;
credo che sia ammalato a causa della infiammazione; non lo so! Può fare
male fare all'amore: si rimane incinta con una goccia di pipì!". E
la seduta dopo la paziente indica il proprio ventre dicendo che le fa
male. Il terapeuta comprende che, al di là della fantasia/desiderio di
essere incinta, la paziente sta recuperando il suo sé corporeo e che
questa ri-personalizzazione somatica non può avvenire senza un certo
dolore.
Trascorso un mese ancora, il terapeuta è portato a pensare che quando
Antonella fornisce la risposta "niente" alla richiesta di
comunicare cosa le stia passando per la mente ora questa risposta può
avere un significato diverso rispetto a prima, quando la paziente mostrava
un'enorme difficoltà a “pensare i propri pensieri”. Adesso la stessa
risposta può anche essere interpretata come una forma di resistenza, dato
che la paziente sembra aver acquisito una maggiore coscienza di sé ed una
minore precarietà del sentimento di identità personale.
Verso la fine del dodicesimo mese, si verifica un’improvvisa
interruzione del trattamento. Il terapeuta, infatti, improvvisamente è
obbligato dall'azienda sanitaria locale, suo malgrado, ad utilizzare tutto
il congedo ordinario in precedenza accumulato per essere sostituito da un
collega più anziano smanioso di fare, per un breve periodo, esperienza
della psichiatria di territorio.
L'assenza del terapeuta dal presidio ambulatoriale non è eccessivamente
lunga (poco più di un mese) ma risulta sufficiente perché Antonella, che
nel frattempo non era stata più seguita da alcuno psichiatra, ripiombi
nello stato psichico iniziale; anche perché il padre della paziente - che
in precedenza aveva sempre accompagnato la figlia presso l'ambulatorio
regolarmente tre volte alla settimana per le sedute - pur avendo aderito
formalmente ad una ripresa del trattamento, trova il modo, adducendo di
volta in volta varie scuse, di saltare la maggior parte degli
appuntamenti. Così l'incontro tra Antonella ed il suo terapeuta diviene
un evento del tutto sporadico. A tutto ciò anche Antonella contribuisce,
per la sua parte, rendendo interminabili i preparativi ogni volta che deve
uscire da casa, così come avveniva agli inizi dalla cura.
Il terapeuta forse potrebbe cercare di proseguire il suo lavoro recandosi
a domicilio della paziente, ma varie considerazioni gli fanno scartare
l'idea. Innanzitutto, il timore che ulteriori possibili interventi
burocratici possano nuovamente vanificare gli sforzi terapeutici sostenuti
e causare nella paziente nuove regressioni psichiche; inoltre, il timore
che il trasferimento delle sedute a casa della paziente possa
rappresentare un mutamento troppo radicale rispetto al setting
psicoterapeutico precedentemente istituito e che tale cambiamento possa
eventualmente scatenare nella paziente, che nel passato aveva anche
tentato il suicidio, eventuali emergenze psicopatologiche, difficilmente
controllabili senza il supporto di una équipe territoriale in grado di
fornire, all’occorrenza, un’adeguata assistenza domiciliare ad
integrazione del lavoro clinico psicodinamico; infine, verosimilmente,
oltre la consapevolezza di un contesto generale terapeutico divenuto
abbastanza ostativo, ad un livello meno conscio, lo stress per il carico
psico-emotivo terapeutico precedentemente sostenuto e l’aumentato timore
(naturalmente in una dose accettabile esso è generalmente presente in
ogni psicoterapia) di fallire nella cura.
******************
COMMENTO
di Alfredo Anania
******************
Il caso sopra descritto, lascia al lettore l’amaro in bocca per vari
motivi: innanzitutto, una cura che sembrava promettente, pur con tutte le
difficoltà del caso, viene comunque interrotta e la paziente, che appare
fragilissima a causa della sua malattia, sembra destinata a ripiombare
irrimediabilmente nel suo guscio difensivo psicotico; in secondo luogo,
alla fragilità della paziente corrisponde anche una qualche fragilità
dello psicoterapeuta, nel senso che lo psichiatra curante si mostra facile
allo scoraggiamento e privo di quella capacità di costanza necessaria a
mantenere comunque una relazione terapeutica, ciò anche in considerazione
del transfert visibilmente positivo e della compliance sin dall’inizio
della psicoterapia mostrati della paziente anche se in una forma sui
generis per via della sua psicosi; infine, sembra paradossale il modo
d’interferire da parte amministrazione sanitaria locale sull’assetto
operativo del servizio psichiatrico e, pertanto, indirettamente sulla
relazione terapeutica, in una forma così burocraticamente selvaggia da
apparire inverosimile se non risultasse così drammaticamente vero che
non-infrequente nella sanità pubblica (e forse anche in quella privata)
intervengano fattori estranei alla cura e alla relazione terapeutica e più
intimamente connessi a giochi di potere, intrallazzi e cose di questo
genere
Non è mai abbastanza ripetere la fondamentale importanza del “lavoro
d’équipe” nelle istituzioni psichiatriche, infatti, classicamente
“il lavoro d’équipe si rende necessario quando le forze del singolo
non sono sufficienti”! Da diversi anni si è affermata l’idea che
nella cura delle psicosi è preferibile un lavoro multimodale da parte di
un’équipe che possa operare funzionalmente intervenendo a diversi
livelli (terapia farmacologia e psicoterapia individuale, terapia di
gruppo, terapia della famiglia, arte-terapia, terapia occupazionale,
tecniche di riabilitazione e di risocializzazione) in vari momenti secondo
una programmazione decisa dall’équipe stessa attraverso riunioni
periodiche collegiali finalizzate a discutere e valutare l’evoluzione
clinica del caso e a coordinare gli interventi ritenuti necessari. È
evidente che essenziali al buon funzionamento dell’équipe quale gruppo
di lavoro sono due condizioni: la prima è che il conduttore dell’équipe
abbia un’adeguata formazione psicodinamica e gruppale; la seconda è che
tutti gli operatori abbiano una formazione al lavoro d’equipe. A suo
tempo ho proposto di sostituire il modello classico
dell’“orchestra”, per metaforizzare il funzionamento dell’èquipe,
con il modello del “gioco degli scacchi”: ove ogni pezzo della
scacchiera può eseguire solo quelle “mosse” che gli sono peculiari e
muoversi nel modo strategicamente più conveniente (ad avviso del
giocatore; nel nostro caso ad avviso dell’équipe nel suo insieme
[“group mind”]). Ritengo che il modello da me proposto ha il vantaggio
di non confinare l’equipe al ruolo in un certo senso di passiva
esecuzione, come fa l’orchestra, di partiture, talora pur sublimemente
interpretate, ma composte in genere da altri; al contrario, la metafora
del gioco degli scacchi valorizza la possibilità dell’équipe di
operare con una “mente” strategica e creativa che predisponga gli
interventi operativi multimodali in modo coordinato e con duttile
adattamento all’effettiva realtà (clinica ed ecosistemica) che si va
evolvendo.
Purtroppo sono ancora molto rare istituzioni psichiatriche, come ad
esempio Chestnut Lodge, predisposte per ospitare a lungo pazienti
psicotici trattati con psicoterapia analitica intensiva (cinque giorni
alla settimana per un periodo di anni che varia tra i 5 e i 15 anni,
secondo la gravità del caso clinico) sino alla possibile guarigione e
dove l’intero staff ha un considerevole livello di formazione
psicodinamica (ad esempio, anche gli infermieri hanno nel proprio bagaglio
formativo qualche anno di analisi personale). Il riferimento a questo tipo
di ospedali e comunità terapeutiche può servire anche a citare
psichiatri-psicoanalisti, come Harold F. Searles, i quali hanno dedicato
la loro vita professionale al trattamento psicoanalitico delle psicosi e
le cui pubblicazioni, basta citare di Harold F. Searles "Scritti
sulla Schizofrenia" (Boringhieri Ed; Torino; 1974), possono chiarire
molte delle profonde dimensioni relazionali (intravedibili anche nella
vicenda terapeutica sopra raccontata) che si sviluppano tanto nel paziente
che nel terapeuta nel corso della psicoterapia intensiva di una psicosi.